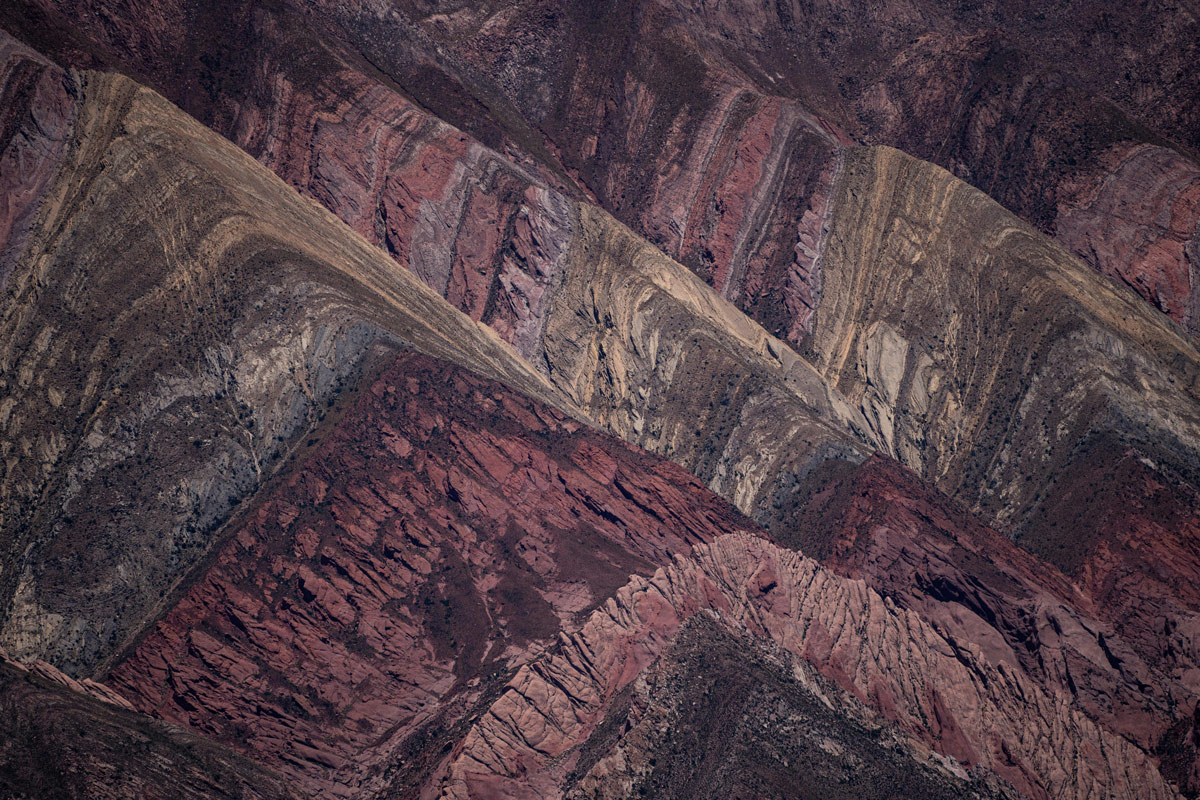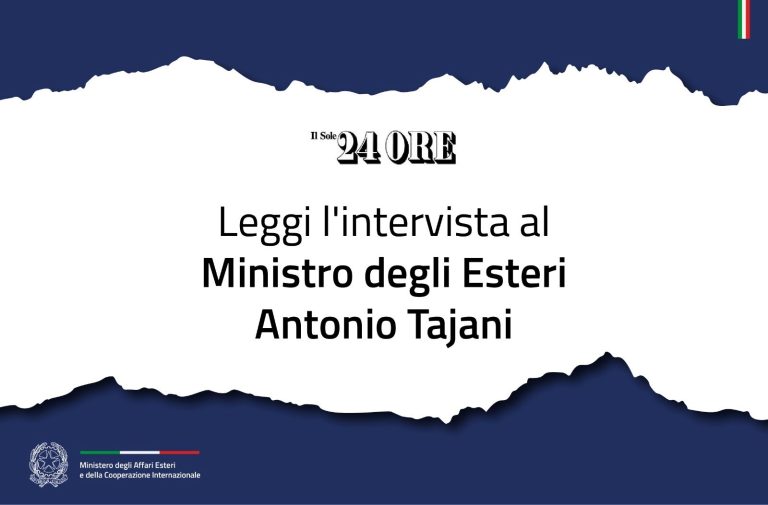Una nuova rivoluzione mineraria potrebbe ridefinire il ruolo del Brasile nell’economia globale: non più solo fornitore di materie prime tradizionali, ma attore centrale nella transizione verso un futuro a basse emissioni. A dirlo è un recente documento ufficiale del Ministero degli Esteri brasiliano, che analizza la crescente centralità del Paese nel mercato mondiale dei minerali strategici. L’obiettivo è chiaro: rendere il Brasile un fornitore affidabile e sostenibile di risorse chiave per la transizione energetica, promuovendo al contempo investimenti e tecnologia per aumentare il valore aggiunto dell’intera filiera.
Il piano brasiliano si basa su tre assi fondamentali: semplificare le autorizzazioni ambientali, attrarre investimenti attraverso incentivi mirati e promuovere pratiche sostenibili e legali. Al centro, un elenco di minerali strategici suddivisi in tre categorie: quelli soggetti a forti importazioni (come potassio, fosfato e zolfo), quelli necessari per tecnologie avanzate (come litio, terre rare, cobalto e nichel) e quelli che generano surplus commerciali (come ferro, rame e oro).
Per valorizzare queste risorse, sono stati lanciati un nuovo piano decennale di mappatura geologica – solo il 35% del territorio è oggi esplorato – e un Fondo Pubblico-Privato da 200 milioni di dollari dedicato a finanziare fino a 20 PMI attive nel settore. In parallelo, l’organizzazione governativa dedicata al finanziamento della scienza e della tecnologia Finep e la Banca Brasiliana di Sviluppo (BNDES) hanno aperto un bando da 820 milioni di euro per sostenere progetti legati a batterie, fotovoltaico e magneti.
Nonostante l’enorme potenziale, il Brasile oggi esporta quasi tutte le terre rare estratte alla Cina per il trattamento. Per colmare questo gap, si punta su collaborazioni come la Minerals Security Partnership, cui partecipa anche l’UE. Tra i siti con alte potenzialità, la miniera di Serra Verde (Goias), attiva dal 2023, che utilizza argille ioniche a basso impatto ambientale per produrre terre rare magnetiche ad alto valore (neodimio, disprosio, ittrio). Se i progetti in corso andranno a regime, il Paese potrà coprire fino al 10% della domanda mondiale entro il 2030.
Paradossalmente, il boom dell’export verso la Cina resta centrale: solo nel primo trimestre 2025, le vendite di rame brasiliano al colosso asiatico sono cresciute del +180% (331 milioni di dollari), mentre manganese e ferronichel hanno rispettivamente segnato +310% e +253%. La dipendenza da Pechino è anche una delle criticità: molte imprese e istituzioni brasiliane stanno cercando di rafforzare la capacità nazionale di raffinazione e trasformazione.
Il Brasile è inoltre il maggiore importatore mondiale di fertilizzanti (attualmente ne produce solo 5-7 milioni di tonnellate su un fabbisogno di oltre 45 milioni), mentre sul litio sono in corso trattative avanzate con la russa Tenex per uno sfruttamento congiunto. Sempre con la Russia, sono stati siglati accordi anche per l’uranio: il Brasile è il settimo produttore mondiale e ha avviato un nuovo programma nazionale con mappature geologiche aggiornate. La miniera di Caetité (Bahia) produce 400 tonnellate di triossido di uranio all’anno, con parte del materiale arricchito in Russia e poi reimportato per alimentare centrali come quella di Angra dos Reis.
Secondo la società di consulenza Deloitte, una piena valorizzazione dei minerali strategici potrebbe aggiungere fino a 6 miliardi di dollari al PIL brasiliano entro il 2030 e ben 48 miliardi al 2050, con una raffinazione interna più diffusa. Progetti pilota come MagBras (produzione di magneti con neodimio, ferro e boro) sono un primo passo verso una filiera integrata che spazia dall’estrazione al riciclo. In questo ecosistema emergente partecipano oltre 28 imprese, tra cui Stellantis, WEG e Vale.
La sfida è costruire un’industria mineraria nazionale innovativa, sostenibile e strategica per il futuro dell’energia verde e farlo valorizzando le sue enormi risorse e aprendosi a partnership globali. Una sfida che potrebbe cambiare non solo l’economia brasiliana, ma anche gli equilibri geopolitici delle catene globali del valore.